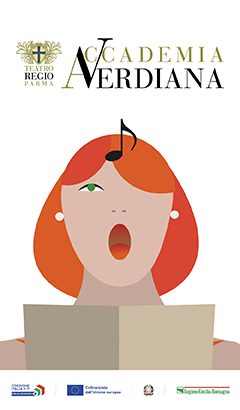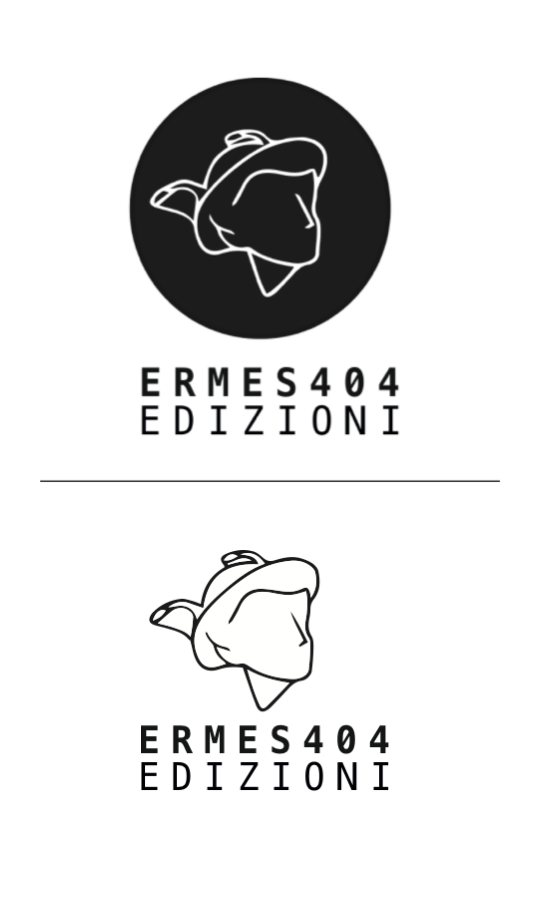Glenn Gould lettore-narratore
di Sibelius
Autore: Matteo Poiani
Ovviamente tra tutte queste stranezze non poteva mancare la registrazione delle opere pianistiche di Jean Sibelius, avvenuta nel 1977. Se Sibelius, e non a torto, è conosciuto per le sue opere sinfoniche tardo romantiche, in particolare la seconda sinfonia e il concerto per violino, Gould deve concentrarsi sulle opere meno conosciute, cioè quelle per pianoforte. L’atteggiamento non snobistico di Gould fa sì che la sua attenzione si sia focalizzata sulle opere cadute nell’oblio. Nel catalogo ci sono opere minori, come moltissime bagatelle, ma anche tantissime Romanze senza parole e anche una Sonata. La qualità di Sibelius come compositore per pianoforte si può vedere in contrasto al sinfonico tardo romantico. In un’epoca di predominio dell’orchestra, pensata come medium della vera musica, non si cimenta in un pianoforte che la eguagli, ma piuttosto nel contrario, cioè all’essenziale. La sua scrittura è asciutta, il suo contrappunto sobrio pre-classico. Non si ricerca una trama sonora altra da portare sul pianoforte, ma una musica per pianoforte. Nelle sonatine, composte durante le ardite sperimentazioni formali della Quarta sinfonia, vengono risaltati i rapporti armonici con una regolarità architettonica affatto semplice e priva di ampi sviluppi interni. In questa semplicità Gould mostra al lettore le insidie interne, gli eterni ritardi delle esposizioni armoniche di Sibelius, gli sviluppi dal sapore mozartiano che puntano direttamente alla ripresa. In questa sobrietà si cercano gli enigmi, si vogliono scovare le riprese degli antichi (Haydn, Mozart, Beethoven,…) aggiungendo quel tocco di curiosità a tutto ciò che appare semplice.
La curiosità di Glenn Gould è per il repertorio, quello minore post-romantico, da tutti ignorato, ma che nasconde enigmi ancora oggi interessanti per noi.
https://www.youtube.com/watch?v=QB1PLlnGYm8&start_radio=1&list=RDQB1PLlnGYm8
Come si è accennato nell’introduzione, Gould lavorò assai anche su Strauss. Tim Page nella curatela pone gli scritti di Strauss e di Sibelius vicini, così da tenere unito quell’amore di Gould per il “conservatorismo relativo” della prima metà del novecento. Richard Strauss non è del tutto estraneo a Sibelius, e c’è un motivo perché entrambi furono studiati da Glenn Gould. Innanzitutto a Strauss vengono dedicati più scritti, più attenzione almeno nella riflessione teorica, mentre a Sibelius vengono dedicate poche pagine e registrazioni molto tardive. Quasi coetanei, ebbero la loro fortuna dopo la Prima Guerra Mondiale, con la première del Rosenkavalier e la stesura della Quarta Sinfonia. Negli anni seguenti però presero due strade differenti: mentre Sibelius scelse il silenzio (quasi trentennale), Strauss optò per una scrittura spiccatamente antimodernista. Ma non fu del tutto così, in fin dei conti quest’ultimo “embraced indirection, the manipulation of fragments, the construction of memory, and the primacy of irony and resignation, strategies located both in the artificiality of music’s material and its susceptibility to connections and analogies with the linguistic, mentre Sibelius “in his maturity appropriated a constructive modernist architectural model for writing music”.
Il loro approccio verso il futuro era completamente diverso e quegli enigmi che Sibelius vedeva nella vita furono presi da Gould nelle piccole pagine pianistiche, e furono portati ai suoi, folli, lettori.
Written by Matteo Poiani
Articoli correlati
Giovanni Gabrieli: la sonorizzazione del potere
n organizzatore di grandiosi eventi musicali. Così si potrebbe sintetizzare il ruolo di Giovanni Gabrieli dal pulpito dell'organo in San Marco, nella Venezia del tardo Cinquecento. Occorre però capire la natura del suo principale posto di lavoro e...
Successi dimenticati: Il Concerto di Marie Jaëll | Violoncello In-Audito
a vita di Marie Jaëll è ricordata per un primato storico: è la prima donna a essere ammessa come membro attivo della Società dei Compositori di Parigi. Ma è molto altro; straordinaria pianista, compositrice apprezzatissima da colleghi illustri,...